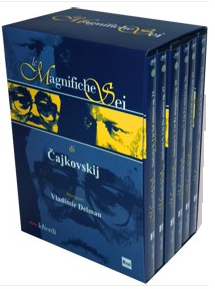Ieri era la quinta e penultima rappresentazione, alla Scala, per il Tannhäuser di Mehta-Fura, dopo accoglienze, diciamo così… mixed. Teatro pieno, ma non pienissimo, e successo quasi pieno per tutti.
Tanto per entrare direttamente in-medias-res, sappiamo come Wagner avesse i suoi (buoni) motivi per ambientare l'opera in Germania, precisamente in Turingia, con tanto di meticolosi riferimenti logistici a due località nei pressi di Eisenach (città natale di un certo Bach - si noti bene - non di Buddha!): il castello della Wartburg, che si trova a meno di 2Km a sud-ovest della cittadina, e il fantomatico postribolo di Venere (il Venusberg) che nella versione parigina è da Wagner dislocato con temeraria precisione presso l'Hörselberg, 5Km - o giù di lì - ad est della stessa Eisenach.
Ecco cosa scrive Wagner sulla partitura d'orchestra, Atto I, Scena III, al momento per Tannhäuser di tornare all'aria aperta, dopo la sbornia del Venusberg: Tannhäuser, che non ha abbandonato la propria positura, si trova improvvisamente trasportato in una bella valle. Cielo azzurro, limpida luce del sole. A destra, sullo sfondo, la Wartburg; a sinistra, in lontananza, il Hörselberg. (…) Nel frattempo, da dietro la scena e da molto lontano, come se venisse da Eisenach, si ode il rintocco delle campane di una chiesa. Insomma, Wagner quasi-quasi ci dà le coordinate GPS del metro-quadro su cui Tannhäuser si trova: lui è più o meno a metà strada fra Hörselberg e la Wartburg (più vicino a quest'ultima) ed ha alle spalle Eisenach. Da qui in avanti tutta l'Opera è ambientata inequivocabilmente in quei precisi paraggi. Così come l'Aida è ambientata in Egitto e i Meistersinger a Norimberga, e la Tosca a Roma, la Bohème a Parigi (che dire di una Bohème ambientata a Mumbay, con Rodolfo che, affacciato alla finestra, canta: "Nei cieli bigi guardo fumar dai mille comignoli Parigi"?)
Ma qui Wagner non viene preso alla lettera (e neanche sul serio, per la verità) e perciò abbiamo un Tannhäuser indiano, in omaggio al Maestro, ovviamente. Avesse diretto Salonen, si andava in Finlandia, col Venusberg collocato in una gigantesca sauna pubblica. Dirige Chung? In Korea, no problem. Dudamel? La Wartburg di Maracaibo, perbacco, chi non la conosce?
Insomma, Padrissa e i suoi sono in grado di ambientare qualunque opera in uno qualunque dei 190 (o quanti sono) Paesi del pianeta. L'unico problema che hanno è trovare un direttore all'altezza nel Burkina-Faso o all'Isola di Pasqua!
Viceversa, sarei pronto a scommettere che – avesse Wagner ambientato la sua storia in India - Padrissa ce l'avrebbe trasferita in Turingia (smile!)
E sempre facendo cose divertenti, mica pizza&fichi! (Del resto, chi non si è mai divertito leggendo la famosa tragedia Ifigonia in Culide?)
Insomma, Tannhäuser assurto al rango di divertissement, ohibò! E dobbiamo consolarci, perché in giro c'è di molto, ma molto peggio.
Leggendo il corposo programma di sala abbiamo la conferma (non che avessimo dubbi) che Padrissa&C sono gente che studia bene i soggetti da mettere in scena. Quindi sanno benissimo che, sul piano esteriore (e superficiale?) del contenuto, Tannhäuser non racconta miti, ma casomai storie medievali (e per buona parte vere) con personaggi e luoghi squisitamente autentici e germanici; sul piano filosofico-religioso, mostra il contrasto insanabile (o sanabile solo una volta passati all'altro mondo) fra carne e spirito, fra l'impulso animalesco – e in quanto tale nemmeno poi peccaminoso – verso eros e sesso, e l'anelito umano verso il trascendente e il divino; infine, sul piano artistico, descrive (autobiograficamente) lo straniamento dell'artista-innovatore dalle consuetudini e dalle (più o meno ipocrite o interessate) convenzioni cui l'establishment è ancorato, e con le quali è però costretto fatalmente a fare i conti o addirittura a venire a patti, o a scontrarsi mortalmente. Addirittura Padrissa&C intendono dedicare questo allestimento a tutti i Tannhäuser di questo mondo, teste matte da Giordano Bruno a Michael Jackson, passando per Richard Wagner e John Lennon! Lodevole intenzione davvero.
Siccome però il pubblico è quello che è (e secondo alcuni non è cambiato troppo dai tempi di Parigi 1861, Jockey Club di buona memoria) è meglio non andare troppo sul difficile, e quindi si parte mostrando immagini, filmati e ologrammi di un bordello in piena regola (peraltro questo combina perfettamente con ciò che scrive Wagner nel libretto, cose del tipo: si formano coppie in cui ciascuno trova l'oggetto dei propri desideri, e poi si confondono e rimescolano… e subito dopo: le Baccanti eccitano gli amanti a una lussuria sempre più sfrenata. Costoro, inebriati, si abbandonano ad ardenti amplessi.) Se si può fare qui una critica, è di tipo economico: quanto sarà costato al regista (cioè dire: a NOI) girare tutte quelle scene con innumerevoli ragazze e ragazzi, tassativamente nudi ed aggrovigliati? Quando invece Padrissa e i suoi qui potevano tranquillamente propinarci immagini di filmetti groupsex o gangbangorgy scaricate gratis da internet, così dispensando Lissner dal prosciugare il FUS, e senza per questo creare scandalo, né essere irriverenti o dissacranti nei confronti dell'Autore.
Nel Venusberg, mentre la Gertseva-Venus è sufficientemente nuda, e mostra così le sue – di gran lunga migliori – qualità, il protagonista Robert Dean Smith è coperto da regolamentare pastrano, il che ci consente di tenere aperti gli occhi mentre canta (passabilmente, benino o così-così, le sue lodi-maledizioni). Ma, dopo essere faticosamente sfuggito al bordello dall'aria divenuta ormai irrespirabile, dove si va a cacciare il povero Tannhäuser? Nella severa Wartburg, direte voi, tempio della virtù e dell'arte. Ecco cosa vediamo all'inizio del secondo atto: mentre Elisabeth saluta la teure Halle, ci sono simpatici ragazzi e ragazze che fanno un balletto tipo Smeraldo anni'70. Ma non basta, quando arrivano gli ospiti, sul solenne canto Con gioia salutiamo la nobile sala dove sempre e soltanto arte e pace possan dimorare, i ballerini si scatenano ancor più, in una cosa bollywoodiana (io veramente me lo ricordavo come il twist): roba da far pensare al povero Tannhäuser di esser caduto dalla padella nella brace (adesso si capisce bene perché, durante la tenzone, gli prenderà la voglia matta di tornare là da dove era venuto!) Sì, anche Wagner si può ballare, incredibile! Perché, come ad esempio Ciajkovski nello Schiaccianoci, ha scritto musica in 4/4 o 3/4 o 2/4 o 6/8 e così via. Chi ci aveva mai pensato? Brava la Fura a scoprirlo!
Ma a proposito di balletto, bisogna sapere che nel 1860, quando a Wagner finalmente furono aperte le porte dell'Opéra di Parigi (grazie all'intercessione della crucca Pauline von Metternich, che era entrata nelle grazie nientemeno che dell'Imperatore Napoleone III) il compositore fu avvertito che, nel secondo atto dell'opera, doveva essere tassativamente programmato un balletto. Chè a quell'ora i simpatici membri del Jockey Club, dopo essersi ben saziati e abbeverati di champagne, arrivavano a teatro per ammirare le nude gambe (allora non si andava oltre) di compiacenti ragazze che, qualche mezz'ora dopo, sarebbero finite direttamente nei loro letti. Orbene, sembra un'enormità, ma Wagner si rifiutò cocciutamente di sottostare a simile imposizione. E sfidando l'Imperatore in persona (che pagava in toto l'allestimento, si noti bene!) Wagner si rifiutò di infilare un balletto a quel punto dell'opera (considerando già fin troppa concessione la nuova, pornografica scena del Venusberg del primo atto).
Ma a noi che 'cce frega? dice Padrissa, siamo in democrazia, mica in un impero, Wagner è morto, e il balletto lo mettiamo dove ci pare! E infatti il pubblico apprezza molto.
Per la tenzone canora – una scena che si richiama nientemeno che al Symposium di Platone, e sappiamo quanto Wagner ammirasse la Grecia! - ci spostiamo invece al lunapark. Infatti, nell'austera Wartburg (o Bangalore, fate voi, visto che son tutti in turbante) ci sono - ad ospitare i canori contendenti - dei caddy da golf, o macchinine da autoscontro, ciascuna dotata di arpista, una specie di tata (anzi Tata, siamo in India!) o badante del Minnesanger di turno. Invece del motore elettrico, due robusti negroni che spingono e tirano qua e là. Ma tanto ha poco di che vantare austerità, la Wartburg, sappiamo quale indegna gazzarra vi si svolgerà, di cui vien data colpa al povero Tannhäuser, costretto a partire per Roma al seguito di pellegrini inturbantati e circondati da coloratissime, ma un po' fastidiose donnicciole che chiedono la carità (in Turingia proprio così funzionava, sapevate?)
Nel terzo atto tornano i pellegrini da Roma (sempre con donnicciole a latere). Elisabeth attraversa il corteo in cerca del suo Tannhäuser, sperandolo graziato dal Papa. Non ritrovandolo, che fa? Sentiamo Wagner: in atteggiamento doloroso, ma tranquillo (…) con grande solennità canta il suo sacrificio e resta in devota estasi. Insomma, non versa una sola lacrima, ma nobilmente offre la sua vita alla Vergine, per ottenerne l'intercessione in favore del reprobo. Ma una scena così sarebbe poco appariscente, e così il regista fa issare Elisabeth su un trespolo fino a 10 metri di altezza e da qui la pia donna allaga letteralmente di lacrime una piscina che occupa metà del palco. (Insieme alla piscinetta di cristallo del Venusberg, è forse una trovata per pubblicizzare qualche aquafan, visto che si va verso la bella stagione).
Ai bordi della quale piscina arrivano quattro lavandaie a lavare degli enormi panni, che scopriamo servire (una volta stesi, più sporchi di prima!) a proiettarci sopra immagini che supportano la parte cruciale del racconto di Tannhäuser del suo calvario a Roma: l'incontro disgraziato con un Papa talebano che, invece di perdonarlo cristianamente, lo invia direttamente all'inferno. E sulle lenzuola vediamo le immagini di un Papa (in visita in India, 1986?) che Padrissa ha accuratamente scelto fra quelli più retrivi, assolutisti, e diciamo pure repellenti che la storia della cattolica Chiesa ricordi: Woitilaccio! Mancava solo un titolo di giornale: "Giovanni Paolo II copriva i preti pedofili" …ma la regìa è stata pensata quando lo scandalo ancora non aveva occupato le prime pagine di giornali e tv, che peccato!
La scena del funerale di Elisabeth è un pout-pourri di idee genialoidi e di improbabili riferimenti alla biografia di Wagner. Sul laghetto di acqua-pianto, arriva un incrocio di piroga indiana e gondola veneziana, carica di lumini, su cui viene portato il feretro; il che è un incrocio fra Gange e Venezia: il funerale di Wagner a Bollywood? Ma allora qui si scimmiotta per caso lo Herheim del Parsifal attualmente in cartellone al tempio? Sulla trasformazione di Elisabeth in Venere (stella, non tenutaria) bisognerebbe scrivere enciclopedie e libelli, lasciamo perdere, siamo qui per divertirci, mica per pensare.
A proposito, sul programma di sala c'è una dottissima presentazione del professor Quirino Principe, che conclude con una considerazione (a proposito della lingua - originale o italiana - in cui rappresentare l'Opera): Quanti italiani amanti del teatro d'opera, ascoltando Tannhäuser in lingua originale, capiranno la meravigliosa complessità culturale di quest'opera? Vien da ridere, ma ovviamente il professore pensava a Tannhäuser, non al Bruschino o all'Elisir.
In sostanza, oggi ci si accontenta di tener buona ancora – ma per quanto ancora? perché la modernità prima o poi chiederà anche qui il suo pizzo – la musica di Wagner; le parole si lascino pure lì, perché tanto sono solo un ostrogoto grammelot, che serve giusto a far uscire i suoni dalla bocca dei cantanti. Tutto il resto: nel cesso, sostituito da trovate più o meno genialoidi. Che termini usare per operazioni di tal genere? Anticulturale, diseducativa, truffaldina?
Invece: divertimento assicurato, il pubblico ha gradito e – a differenza della prima – non ha contestato nessuno, men che meno il regista (che però non si è fatto vedere al proscenio).
Questo è lo stato-dell'arte, oggi, anno di grazia 2010. E dobbiamo accontentarci, essendoci in giro anche di peggio.
___
La musica.
Mehta non mi è per nulla dispiaciuto. Come già nel Ring ascoltato uno-due anni fa al Maggio, tiene un approccio assai pragmatico, facendo ben emergere il lato italiano (meno male, non indiano!) presente – e come! – in Wagner, particolarmente in opere come questa. Nessuna enfasi gratuita, tempi forse più celeri rispetto ai metronomi di cui Wagner ha disseminato la partitura (ma che lui per primo invitava Kapellmeister e cantanti a prendere abbastanza con le molle, privilegiando la loro personale sensibilità). In un paio di occasioni ha forse lasciato troppa briglia al fracasso dell'orchestra, coprendo le voci, ma in complesso – per me – la sua è stata una direzione lodevole.
Dei cantanti, rispetto al recente Tannhäuser torinese, salverei giusto la Harteros-Elisabeth, gli altri da discreto (Dean Smith, voce debolissima, però, e Zeppenfeld-Langravio) a mediocre (Trekel-Wolfram) a insufficiente (Gertseva). Gli altri ancora, senza infamia, né lode. Bene al solito il coro di Casoni e i piccoli di Caiani.
Oggi si passa però a cose serie, da settimana santa: una passione bachiana all'Auditorium.