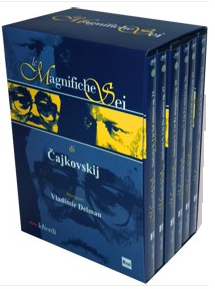Riecco Wayne Marshall in doppia veste di direttore e organista, con un
programma tutto dedicato a Francis Poulenc.
Dopo il Concerto per 2 pianoforti della scorsa settimana, ecco altre due
composizioni dello stesso periodo (gli anni ’30 dello scorso secolo) e una più
tarda (fine anni ‘50).
L’impaginazione del concerto è tale per
cui vi sono impegnati dapprima solo i fiati, poi solo gli archi e infine tutto il
corpo strumentale-vocale de laVerdi: insomma,
una specie di passerella tutta in crescendo per i componenti di questa splendida
realtà.
Il primo dei tre brani in programma è
la Suite
française, composta nel 1935 come musica da eseguirsi in un’opera teatrale: si
tratta di sette brani di danza, di cui sei sono trascrizioni dal musicista
cinquecentesco Claude Gervaise,
mentre una è di mano completa di Poulenc. Il tipo di composizione segue quindi
le indicazioni programmatiche del manifesto
del Gruppo dei Sei (scritto da Jean Cocteau sotto il titolo di Il Gallo e l’Arlecchino): in esso si
irrideva (ma è un eufemismo) a Wagner, Debussy (!?) e a tutte le avanguardie e
si propugnava, fra l’altro, un ritorno alla tradizione, di cui faceva parte
precisamente la forma della Suite,
che storicamente si era costituita come assemblaggio di musiche di danza (nello standard: allemanda, corrente, sarabanda e giga, ma affiancate anche
da pavana, gagliarda, siciliana, saltarello, …)
Quindi un brano neo-classico, che fa un po’ il verso – 15 anni dopo - a
simili iniziative di Stravinski (vedi
il pergolesiano Pulcinella). L’organico
è una piccola orchestra composta da soli 9 fiati (2 oboi, 2 fagotti, 2 trombe e
3 tromboni) più una batteria e un clavicembalo.
Musica pienamente diatonica, come sempre sarà quella di Poulenc, rimasto
del tutto impermeabile alle invenzioni di scuola austro-tedesca; qui basata su
modelli rinascimentali e piena di inflessioni modali. Scarse o del tutto assenti le
modulazioni. Eccone un’interpretazione
di George Prêtre.
___
Si apre con Bransle
de Bourgogne. La Bransle (o Branle, in italiano: Brando) era una danza dal
tempo binario, che prevedeva più che altro spostamenti laterali. Eccone lo
spigliato motivo, preceduto dal rullo del tamburino ed esposto dalle trombe,
cui rispondono gli oboi:
Il brano è monotematico, con la semplice apparizione
di un controsoggetto e di una cadenza. Queste tre componenti vengono ripetute
per tre volte, semplicemente variando la strumentazione o l’ottava di partenza.
La tonalità è SOL sfociante a DO maggiore.
Poi ecco la Pavane,
sull’etimologia del cui nome non c’è unanime accordo: chi la individua nel pavone, chi nell’origine padovana (!)
Si noti come qui Poulenc copi perfettamente la prima
frase di Gervaise (in FA maggiore) mentre per la seconda (che chiude in RE
minore) invece della semplice ripetizione, con i due punti del da-capo, opti
per una impercettibile variante ed una diversa strumentazione:
La sequenza (senza ripetizioni e variata) verrà
ripresa in chiusura, dopo una sezione centrale che presenta due nuovi motivi,
caratterizzati da moderate dissonanze.
Segue una Piccola
marcia in SIb, aperta dagli ottoni con crome sempre staccate:
Dopo che il motivo principale è stato ripetuto, ne
subentra un altro che gli è assai parente; ancora il primo tema ripetuto, poi
due nuovi motivi più mossi che sfociano nella doppia ripresa del tema
principale.
Il quarto brano è l’unico composto da Poulenc e non
preso da Gervaise. Il titolo Complainte
ricorda canzoni malinconiche, cantilene dal soggetto triste. È l’oboe ad
aprirlo, in SOL minore, con una struggente melopea:
Gli fa eco il clavicembalo, poi oboi e fagotti,
infine anche trombe e tromboni. Il brano in realtà fa da introduzione lenta a
quello successivo, cui si concatena senza soluzione di continuità: è un’altra
danza campestre – Bransle de Champagne
– sempre in SOL minore:
Sono le trombe ad esporre inizialmente il motivo che
dominerà l’intera danza. Subito lo riprende il primo oboe. In realtà, al motivo
principale si affianca un controsoggetto tematicamente assai vicino, che lo
accompagna anche alla ripresa, che avviene dopo un intermezzo occupato da
clavicembalo, poi fagotto e tromba.
Il sesto brano è una Siciliana, dal caratteristico ritmo ondeggiante, tonalità DO
maggiore:
Sono ancora le trombe ad esporre inizialmente la
melodia, seguite dai tromboni. Il clavicembalo, poi oboi e fagotti chiudono piuttosto
mestamente la frase musicale, che viene ripetuta da-capo, seguita da una cadenza finale di tromboni e clavicembalo.
Chiude la suite il Carillon, veloce danza (ancora in DO) a forma di Rondo dove sono sempre le trombe ad
introdurre per prime il tema che viene ripetuto e seguito da una risposta in
SOL, pure ripetuta.
Il solo clavicembalo ripete due volte il tema, poi
un nuovo motivo in SOL fa da cerniera portando verso la riproposizione del
primo tema, ancora nelle trombe e poi nel clavicembalo, chiusa da una robusta
cadenza e da due accordi di settima e tonica sul DO.
Ora il clavicembalo torna a ripetere due volte il
tema, poi ecco un nuovo motivo, sempre legato tematicamente ai precedenti,
ripetuto. Quindi torna il tema principale, prima nel clavicembalo, poi nei fiati. È seguito dalla risposta in SOL e poi dalla
cadenza già udita poco prima.
Infine è il tamburino a
preparare la chiusa, dove il tema principale è ripresentato due volte, fino al
conclusivo accordo sulla dominante SOL.
___
Beh, è una cosa semplice-semplice e senza troppe pretese, sono poco più
di 10 minuti di musica, ma gradevole e rilassante, non c’è che dire, che i
ragazzi ci hanno proposto con grande cura, precisione e attenzione ai dettagli,
ricevendo una calorosa accoglienza da un pubblico non proprio oceanico, forse a
causa della ricorrente festività e del ponte incombente.
___
Ecco poi Wayne Marshall sedersi all’organo (e nascondendosi
dietro l’imponente cassone dello strumento) per assumere anche il ruolo di
solista nel Concerto in SOL minore,
finito di comporre, dopo lunga gestazione, nel 1938. Fu un periodo particolare
della vita di Poulenc, che proprio in quegli anni cominciò ad avere visioni…
mistiche, che lo porteranno più avanti a comporre, dopo Les dialogues, proprio il Gloria che chiude la serata.
L’organico strumentale
prevede solo archi e timpani, oltre all’organo; la cui scrittura non dev’essere
proprio proibitiva, per poter essere padroneggiata dalla dedicataria –
Principessa Edmond de Polignac – che
era una musicista dilettante, e soprattutto una grande mecenate dell’arte e
della musica in particolare. La struttura non presenta soluzione di continuità,
nel senso classico, non essendo il Concerto suddiviso in movimenti. Peraltro vi si distinguono sette parti, contrassegnate da Poulenc attraverso precise
indicazioni metronomiche, in aggiunta a quelle agogiche. Una perfetta simmetria
fa alternare sempre un movimento piuttosto lento (1-3-5-7) ad uno veloce
(2-4-6).
Anche qui Poulenc è più che
fedele alla tonalità, semplicemente arricchita
qua e là da qualche dissonanza o digressione del tutto innocenti. Quanto ai
contenuti, pare di trovarsi di fronte ad un certo sincretismo di stili e
stilemi, che parte sì da Bach, ma che non esclude riferimenti a quell’800 romantico
bandito per principio dal manifesto del Gruppo
dei Sei.
___
È un Andante ad aprire l’opera, con l’organo che
espone un motivo pieno di energia, conferitagli dalle coppie di semicrome (che richiamano vagamente l’apertura della settima di Mahler…):


Subito però l’atmosfera diviene rarefatta, sempre
con l’organo in evidenza, interrotto da un pesante accordo degli archi;
risponde l’organo reiterando il motivo introduttivo, che prelude (Molto dolce ed intenso) ad un dialogo
fra archi e organo (tre interventi dei primi e due del secondo) chiuso dal
solista con pesantissimi accordi dissonanti.
Ecco ora il primo dei momenti veloci, un Allegro giocoso, aperto dagli archi e
timpani con un secco accordo di SOL minore subito seguito da un tema assai
agitato (che ha un che di Shostakovich…):


Lo sviluppa anche l’organo, con salite e discese
sulle scale di SIb maggiore e minore, poi di FA# (!) Il tema principale torna
in RE minore, poi si modula a DO maggiore dove violini e viole espongono un
motivo che diventerà una specie di motto per tutte le tre sezioni veloci del
concerto:


L’ostinazione del motivo continua, interrotta
brevemente dal tema principale, poi riprende per chiudere la sezione in SOL
maggiore (accordo però assai sporco!)
con una caparbietà che ricorda nientemeno che Bruckner!


Ora ecco una sezione lenta (subito Andante moderato) dove spetta all’organo esporre un motivo
in LA minore:


È una specie di siciliana
(croma puntata più semicroma) che sfocia in un bellissimo controsoggetto in LA
maggiore:

Una lunga serie di modulazioni ci fa passare per DO#, poi più volte per DO, FA, fino all’emergere di un languido motivo come questo, che ricomparirà ciclicamente nella successiva sezione lenta:


Una lunga serie di modulazioni ci fa passare per DO#, poi più volte per DO, FA, fino all’emergere di un languido motivo come questo, che ricomparirà ciclicamente nella successiva sezione lenta:

Poi ecco un crescendo, sottolineato da veloci biscrome di violini secondi e viole, culminante in una sospensione
che ancora richiama Bruckner:


L’organo suggella il tutto con due
pesantissimi accordi di LA, minore e maggiore.
Ora abbiamo un Tempo Allegro, molto
agitato, introdotto da un motivo in LA minore con ostinate volute attorno
alla tonica, seguito da una risposta molto mossa negli archi:


Anche qui assistiamo a continue modulazioni, finchè
improvvisamente sbuca il motto (qui in REb) nell’organo e poi nei violini:

Spetta al solista condurre ora la danza in modo concitato, ma poi, accipicchia, gli archi sembrano proprio portarci al movimento finale della Patetica (!):

Introducendo quindi una nuova sezione lenta (Molto calmo, lento) dove è ancora l’organo ad esporre un motivo assai struggente:

Poco dopo sono i violini a rispondere riprendendo il bellissimo motivo già udito nel precedente Andante moderato (si noti anche l’inciso del violoncello):


Spetta al solista condurre ora la danza in modo concitato, ma poi, accipicchia, gli archi sembrano proprio portarci al movimento finale della Patetica (!):

Introducendo quindi una nuova sezione lenta (Molto calmo, lento) dove è ancora l’organo ad esporre un motivo assai struggente:

Poco dopo sono i violini a rispondere riprendendo il bellissimo motivo già udito nel precedente Andante moderato (si noti anche l’inciso del violoncello):

Qui l’organo sembra proprio voler disturbare
un’atmosfera di raccoglimento, e spara feroci accordi che distruggono
l’incantesimo, preparando l’arrivo del successivo Tempo dell’Allegro iniziale, dove subito ricompare, in SOL maggiore
e in bella evidenza, il nostro motto:

Motto che terrà ampiamente banco in questa sezione, rimbalzando dal solista agli archi, fino a quando sarà ancora l’organo a porvi fine in maniera a dir poco tracotante, con un accordo ferocemente dissonante: FA# - SIb – DO – MIb – RE – FA.

Motto che terrà ampiamente banco in questa sezione, rimbalzando dal solista agli archi, fino a quando sarà ancora l’organo a porvi fine in maniera a dir poco tracotante, con un accordo ferocemente dissonante: FA# - SIb – DO – MIb – RE – FA.
Sul Tempo
dell’Introduzione, largo riudiamo precisamente il motivo esposto
originariamente dall’organo (la sua prima metà, peraltro) in SOL minore. Poi
l’atmosfera si tinge di religioso raccoglimento. Gli archi disegnano
un’atmosfera rarefatta, in cui la viola fa fiorire il suo nobile canto:

Poco dopo tocca anche al violoncello emergere da questa calma che pare ormai destinata a chiudere l’opera. Invece è l’organo che esplode una cosa che ricorda l’incipit della Toccata e Fuga di Bach, chiamando anche il resto dell’orchestra ad una chiusura pesantissima, su un generale unisono di SOL:


Poco dopo tocca anche al violoncello emergere da questa calma che pare ormai destinata a chiudere l’opera. Invece è l’organo che esplode una cosa che ricorda l’incipit della Toccata e Fuga di Bach, chiamando anche il resto dell’orchestra ad una chiusura pesantissima, su un generale unisono di SOL:

___
Che dire, una composizione un po’ fuori dagli schemi, dalle scuole e dalle
mode del tempo, ma personalmente la trovo più che dignitosa e godibile: per dire,
le Variazioni op. 31 di Schönberg, di
8-10 anni più vecchie, mi lasciano assai meno… tranquillo (smile!)
E Marshall e gli archi de laVerdi ieri ce l’hanno propinata veramente con grande passione, meritandosi una calorosissima accoglienza. Purtroppo la regolazione del volume del suono dell’organo era totalmente sballata, un sacco di decibel di troppo, il che ha soprattutto nuociuto ai passi di concertato, dove il registro pieno dello strumento era tale da sovrastare completamente il suono degli archi.
Marshall ha poi approfittato dell’occasione per esibire ancora le sue doti di organista: già nel Concerto ha infilato, all’inizio dell’ultima sezione, una sua personale e lunghissima cadenza solistica; poi ci ha offerto due bis: il primo era una sua trascrizione del primo tempo della Sinfonietta di Poulenc, il secondo una specie di improvvisazione su uno dei più diffusi ringtone di cellulare, mescolato a melodie (pare) di Glière.
E Marshall e gli archi de laVerdi ieri ce l’hanno propinata veramente con grande passione, meritandosi una calorosissima accoglienza. Purtroppo la regolazione del volume del suono dell’organo era totalmente sballata, un sacco di decibel di troppo, il che ha soprattutto nuociuto ai passi di concertato, dove il registro pieno dello strumento era tale da sovrastare completamente il suono degli archi.
Marshall ha poi approfittato dell’occasione per esibire ancora le sue doti di organista: già nel Concerto ha infilato, all’inizio dell’ultima sezione, una sua personale e lunghissima cadenza solistica; poi ci ha offerto due bis: il primo era una sua trascrizione del primo tempo della Sinfonietta di Poulenc, il secondo una specie di improvvisazione su uno dei più diffusi ringtone di cellulare, mescolato a melodie (pare) di Glière.
___
Dopo l’intervallo arriva il soprano Karina Gauvin, 47enne canadese
francofona, per cimentarsi, con il Coro di Erina
Gambarini, nel monumentale Gloria, opera del 1959-60. La cui prima fu diretta il 14 febbraio 1961 dal
grande Charles Münch a Boston,
città del committente (meglio: della Fondazione del defunto) Koussewitzky.
Un’opera dove – come spesso per la
verità – Poulenc ci mette ingredienti mutuati dalla sua fede religiosa,
mescolandoli con altri francamente irriverenti, se non proprio blasfemi. Si
passa così con la massima disinvoltura da solenni atmosfere chiesastiche a
squarci impertinenti di café-chantant
(che il nostro frequentava con la stessa frequenza di monasteri e basiliche…)
Ma questo è proprio Poulenc, come lui stesso si auto-definiva!
La struttura di questa specie di cantata prevede sei sezioni, in tre
delle quali (3-5-6) oltre al classico coro misto (S-A-T-B) udiamo anche la voce
del soprano solista. L’orchestra è di dimensioni quasi tardo-romantiche, anche
se – per essere un’opera a sfondo religioso – vi manca l’organo.
___
Si inizia con il Gloria
(tempo Maestoso) aperto da un
motivo in SOL maggiore, esposto inizialmente dagli archi, di carattere epico,
che si appoggia sulla sensibile:
L’inciso iniziale, come vedremo,
tornerà proprio nell’ultima sezione dell’opera. Il motivo è ripetuto,
variandone l’armonizzazione finale, per altre due volte, prima dai fiati, poi
dai soli ottoni, e fa da introduzione all’ingresso dei bassi del coro che
espongono il primo verso:
Esso dà l’impronta al resto del
brano, caratterizzato da una struttura di corale,
senza alcun contrappunto fra
le voci (questa peraltro sarà la caratteristica del tessuto musicale del coro
per tutta l’opera: nessuna parvenza di contrappunto, di fuga, di polifonia
delle voci).
La
chiusura, invero bizzarra - una specie di urletto (biscroma-semicroma) seguito
da un accordo (RE-SI) di ottoni gravi, arpa e timpano – sembra anticipare la
leggerezza (non in senso nobile, ma quasi offensivo…) della successiva sezione.
Che è Laudamus te (Molto veloce e gioioso, tonalità base DO).
Introdotto da ridicole crome dei tromboni, ha per lo più un ritmo sincopato, jazzistico
(in termine di metrica, antispasto:
corta-lunga-lunga-corta) qui esemplificato:
Sul Gratias agimus abbiamo un momentaneo ritorno alla serietà dovuta
al… luogo. Ma dopo che il Propter magnam
gloriam tuam (in MIb) ci aveva illuso di un rinsavimento del compositore,
ecco che torna il Laudamus a smentirci, chiudendo addirittura con una specie di
sberleffo:
Per fortuna col successivo Domine
Deus (Molto lento e calmo, SI
minore) dal piano-bar si torna… in
chiesa ed il soprano fa la sua prima apparizione, cantando una severa e nobile
melodia, subito accompagnato dal coro:
Tutta a sezione (strutturata in
tre parti, A-B-A) mantiene una grande compostezza, meritandosi l’ammirazione e
i giudizi positivi che sempre l’hanno accolta.
Ecco
però subito dopo un’altra stramberia di Poulenc, con il Domine Fili unigenite
(ancora Molto veloce e gioioso,
tonalità base SOL) che già dalle prime battute degli archi mostra tutta la sua
vena dissacrante:
E anche la chiusa è in linea
col resto: una specie di sberleffo.
Il successivo Domine
deus, Agnus dei (Ben lento)
reintroduce la giusta atmosfera. Gli strumentini sembrano proprio imitare
l’organo, nella loro introduzione, prima che il soprano faccia la sua seconda apparizione:
Tutta questa sezione è magistralmente
condotta da Poulenc attraverso continue variazioni armoniche (la tonalità è sempre
sfuggente, in chiave mancano gli accidenti) che restituiscono splendidamente il
significato del testo, il richiamo al Signore perché tolga i peccati del mondo.
Il conclusivo Qui sedes
ad dexteram Patris (tempo Maestoso,
poi Allegretto, SOL maggiore) torna ciclicamente
all’origine, a partire dall’inciso che avevamo udito negli archi e che ore compare
negli ottoni:
Esso tornerà ancora a sottolineare
i passaggi salienti del brano. Uno dei quali è rappresentato dall’ingresso del soprano,
sulla prima comparsa dell’Amen:
Mirabile la chiusa, sulla dominante
RE, ultima nota emessa dal soprano, esalando l’ultimo Amen.
___
Marshall ha tenuto, come per il resto della
serata, tempi sempre assai serrati e direi che la cosa sia del tutto condivisibile.
Il coro ha risposto molto bene, sui suoi standard di alto livello. La rotondetta
Gauvin ha sciorinato una bella voce, forse
un poco sforzata e troppo di petto negli acuti, ma insomma ha contribuito al successo
di questo originale (per non dire bizzarro) Gloria.
___
Maggio vede il ritorno sul podio di Zhang Xian con ben
tre concerti consecutivi, il primo dei quali fondato su con un’accoppiata… di famiglia.