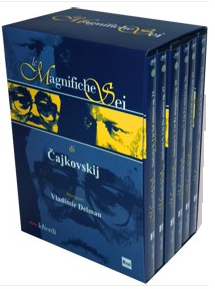Sta per andare in scena al Comunale di Bologna un atteso Werther in cui debuttano Juan Diego Florez nei panni del complessato protagonista e Michele Mariotti alla concertazione.
Il libretto di Edouard Blau, Paul Miller e Georges Hartmann fu derivato, come
sappiamo, dal romanzo epistolare di Goethe
(I dolori del giovane Werther) che
giocoforza dovette essere smagrito per evidenti ragioni di compatibilità con i
requisiti e le esigenze di un melodramma. E purtroppo questa
riduzione/compressione ha comportato una serie di problemi, a partire dalla
stessa definizione delle personalità dei protagonisti, che ahinoi nel libretto
perdono parecchi dei tratti di cui li rivestì il sommo Goethe.
Così Werther ci appare come una sbiadita figura
dell’autentico eroe che in Goethe trabocca romanticismo da ogni sua lettera,
essendo ridotto qui a poco più di un velleitario e malato sognatore; Charlotte
è una ragazza quasi volubile, non dissimula nemmeno la sua attrazione per
Werther e il suo legame con Albert pare giustificato esclusivamente da un
giuramento impostole dalla madre e accettato solo per dovere, mentre la Lotte
di Goethe è una donna con la testa sulle spalle, che ama sinceramente Albert e
per Werther prova un’affinità quasi esclusivamente cultural-spirituale; Albert è per Goethe un personaggio di larghe
vedute, non esita a riconoscere il fascino che Werther esercita sulla moglie, non
teme che i due si incontrino anche da soli, proprio perchè sicuro del rigore e
della fedeltà della sua Lotte, mentre nel libretto assume via via i tratti di
un marito geloso, che addirittura arriva carognescamente (assai più che nel
romanzo, dove si dichiara contrario per principio al suicidio) a costringere la
moglie a consegnare l’arma mortale a quello che ormai considera un pericoloso
rivale.
L’estrema compressione dei tempi dell’azione - in Goethe, dopo un’introduzione
che data dal 4 maggio, si va dal 16 giugno 1771 (incontro di Werther con Lotte)
fino alla notte dell’antivigilia di Natale del 1772; nel libretto il tutto
inizia in un non meglio precisato giorno di luglio per concludersi nella notte
di Natale dello stesso anno (178x) cioè poco più di 5 mesi, nei quali i
librettisti hanno dovuto liofilizzare le vicende di 18! - ha finito per creare
nel libretto parecchie inconsistenze e salti logici piuttosto evidenti.
Dunque l’opera inizia in luglio quando Werther, che a mala pena conosce
il borgomastro (padre di Charlotte) si reca a casa di costui (facendosela
indicare da un contadino) per prelevarvi una ragazza da accompagnare ad una
festa: è lì che incontra per la prima volta Charlotte, che immediatamente lo
colpisce... a morte. La serata passata in sua compagnia pare avere effetti
afrodisiaci anche sulla ragazza-madre (ops... madre nel senso di sorella
maggiore di 7 fratellini, come lei orfani della mamma) che arriva persino a
scordarsi di essere promessa sposa a tale Albert, giovane, serio e
intraprendente uomo d’affari. Costui torna proprio quella sera da un viaggio di
lavoro e così il povero Werther deve constatare che la sua Charlotte si è
trasformata in un miraggio.
Ora attenzione: nel secondo atto – siamo a settembre - Albert e Charlotte
conversano amabilmente davanti alla chiesa e ci fanno sapere di essere
felicemente coniugati da tre (!) mesi. Beh, dovremmo pensare che Albert stia un
filino esagerando, a meno che il primo atto non si fosse aperto e chiuso il 1°
luglio, il matrimonio celebrato immediatamente e il secondo atto sia ambientato
il 30 settembre... ma insomma, non sottilizziamo. Ciò che ci interessa è invece
scoprire Werther che sembra pedinare e scrutare da lontano i due coniugi, forse
per verificare la solidità del loro legame o intravedere qualche falla (che gli
dia delle speranze per il futuro) nella predisposizione di Charlotte verso il
marito. Di più: Albert scorge Werther, lo avvicina e mostra di conoscerne i sentimenti
verso Charlotte: sentimenti che lui non si sente di biasimare (sua moglie è
talmente a modo che chiunque se ne
potrebbe innamorare). Werther incontra poi Charlotte che lo congeda invitandolo
a partire, ma giustificando la loro separazione esclusivamente con un dovere cui lei si deve assoggettare (lei
dice Albert mi ama, ma mai... Io amo Albert!) Fatti un bel viaggio e
scordami... tutt’al più torna per gli auguri di Natale! Alla notizia che
Werther partirà Albert mostra i primi sintomi della gelosia, chiudendo l’atto
con un sinistro sguardo alla moglie turbata e mormorando Egli l’ama...
Domanda: preso atto di questo scenario, è plausibile ipotizzare che nei
(meno di) tre mesi trascorsi Werther sia stato ospite quasi quotidiano a casa
degli sposini Albert-Charlotte e vi abbia incontrato la donna a quattr’occhi,
intrattenendo con lei rapporti assai sospetti? Parrebbe proprio di doverlo
escludere... e invece è ciò che scopriamo inopinatamente nel terzo atto.
Che si apre alle 5 del pomeriggio della vigilia di Natale, in casa di
Albert-Charlotte. Questa scena è completamente inventata dai librettisti, non
ve n’è traccia alcuna in Goethe: Charlotte è alle prese con una catasta di
lettere inviategli nei tre mesi precedenti da Werther, auto-esiliatosi chissà
dove, proprio su suo consiglio. Ma proprio come lei gli aveva suggerito, il
giovane spasimante arriva a casa sua e - ohibò – assistiamo qui ad un’assurda,
ingiustificata e impossibile serie di ricordi di momenti di grande intimità
intercorsa fra i due in quelle stesse stanze - la casa di Albert! - in passato.
E quando, di grazia? Fra luglio e settembre, quando Charlotte e Albert erano
sposini freschi-freschi e – ne siamo stati testimoni - Werther poteva solo
spiarli di lontano? O fra ottobre e Natale, quando Werther era chissà dove e
non poteva che scrivere lettere su lettere? Ahi ahi, qui tutto scricchiola
maledettamente!
Come si spiega questo clamoroso abbaglio? Precisamente con l’esigenza dei
librettisti di comprimere il testo (e i tempi) di Goethe. Come vanno le cose
secondo il grande drammaturgo? Ecco qua: dopo il primo incontro al ballo
(16/6/1771) Lotte e Werther si ritrovano a casa della ragazza (del borgomastro
quindi, non di Albert!) e lei gli rivela tranquillamente di essere fidanzata e
innamorata di Albert, che è assente per affari e tornerà 40 giorni dopo, il
30/7/1771. Durante questi 40 giorni Werther incontra più volte Lotte a casa sua
(ne fa cenno in due lettere, del 13 e 16 luglio) e fra i due si stabilisce una
certa intimità (canzoni che lei suona al clavicembalo, letture un poco galeotte,
le loro mani che si sfiorano, sguardi languidi) che lui interpreta (erroneamente,
come ci verrà confermato dai successivi sviluppi) come amore da parte della ragazza.
Ecco, ora abbiamo capito a quali incontri si
riferiscono i ricordi della sera di Natale, a casa di Albert, nel libretto
dell’opera: peccato che però siano relativi a fatti (raccontati da Goethe) avvenuti
a casa del borgomastro prima del
matrimonio di Lotte, fatti che sono del tutto incompatibili con la trama del
libretto, che ci mostra Albert tornare la sera stessa del primo incontro fra
Werther e Charlotte, cui seguirà a tambur battente il matrimonio, mentre il
povero Werther (chiusura atto primo) è addirittura disperato!
Il racconto di Goethe prosegue poi con grande dovizia di particolari e
con assoluta coerenza: dopo il suo ritorno Albert fa amicizia con Werther e lo
invita (12 agosto) a casa sua (qui Werther vede le pistole fatali). Il 10
settembre Werther annuncia a Lotte e Albert la decisione di trasferirsi e a
fine mese prende impiego all’ambasciata. Poi un lungo black-out, rotto dopo quasi 4
mesi (il 20/1/1772) quando Werther scrive a Lotte ribadendole il suo affetto; il
20/2/1772 manda a lei e Albert una lettera di felicitazioni per il loro
avvenuto matrimonio (!) Il 19/4/1772 si congeda dall’impiego e torna. Solo dopo
altri 5 mesi, il 12/9/1772, incontra nuovamente Lotte a casa sua e di Albert;
la rivede regolarmente, sempre a casa sua, a ottobre, novembre e dicembre,
approfittando delle continue assenze di Albert, impegnato in viaggi d’affari
(sono passati 7 mesi dal matrimonio...) ma si tratta di incontri che (perlomeno
nelle intenzioni di Lotte) si mantengono sul piano di amicizia e cortesia,
nulla più.
Anche il finale dell’opera diverge abbastanza da quello del romanzo: è in
effetti assai più melo-drammatico! Ma
a spese anche qui di un affastellarsi di eventi invero al limite
dell’incredibile, se non del ridicolo: Werther che fugge dalla casa di Albert,
dopo quella drammatica scenata con Charlotte, Albert che rientra un minuto dopo
e trova Charlotte sconvolta, il domestico che arriva proprio in quel momento
con la missiva di Werther, Albert che ordina bruscamente alla moglie di
consegnargli le pistole, Charlotte che corre fuori in scia al domestico per cercare
di raggiungere Werther prima che si spari... (!?) Charlotte trova Werther
ancora vivo e gli dichiara il suo amore; Werther (che come ogni tenore che si
rispetti, prima di morire canta ancora un’ultima aria) muore contento nelle sue
braccia, mentre si odono gli allegri canti natalizi dei fratellini di Charlotte.
Nel romanzo le cose vanno in modo assai più plausibile, ordinato e
verosimile: la domenica prima di Natale Albert chiede a Lotte di diradare i
suoi incontri con Werther, così lei lo invita a rifarsi vivo non prima del 24
sera (giovedi). Lunedi 21 Werther comincia a scrivere l’ultima lettera a Lotte contenente
propositi suicidi (verrà trovata nella sua stanza); va a casa del padre di
Lotte e saluta i bambini; la sera torna (anzitempo, rispetto alla richiesta
della donna) da Lotte e la trova sola in casa; lei è infastidita, ma lo invita
gentilmente a leggerle qualcosa e lui le sciorina una montagna di versi di
Ossian, che la turbano profondamente; quindi le si avventa addosso coprendola
di baci; Lotte si ritrae sconvolta e si chiude in camera; Werther fugge, torna
a casa: il mattino dopo (22/12) completa la lettera per Lotte; poi manda ad
Albert il biglietto con la richiesta delle pistole in prestito; Albert e Lotte
sono a casa e ricevono il servo di Werther con la lettera: Albert chiede a
Lotte di consegnargli le pistole e aggiunge auguri di buon viaggio per Werther;
è l’ora di pranzo, Werther vaga ancora per il territorio e poi torna a casa nel
pomeriggio e vi trova le pistole; a mezzanotte in punto si spara nell’occhio
destro. L’indomani (23/12) viene trovato ancora in vita, muore senza riprendere
conoscenza, verso mezzogiorno; la sera alle 11 viene sepolto secondo le sue
volontà. Dal giorno precedente Lotte, sconvolta e prostrata immaginando il
peggio, non si è più mossa da casa sua.
___
Beh, dato a Goethe quel ch’è di Goethe, diamo doverosamente a Massenet ciò che gli spetta. Qui lo fa
il grande Antonio
Pappano, in occasione di una produzione della ROH con Grigolo e la DiDonato.
___
La prima di giovedi 15/12 viene
trasmessa da Radio3, ore 20.